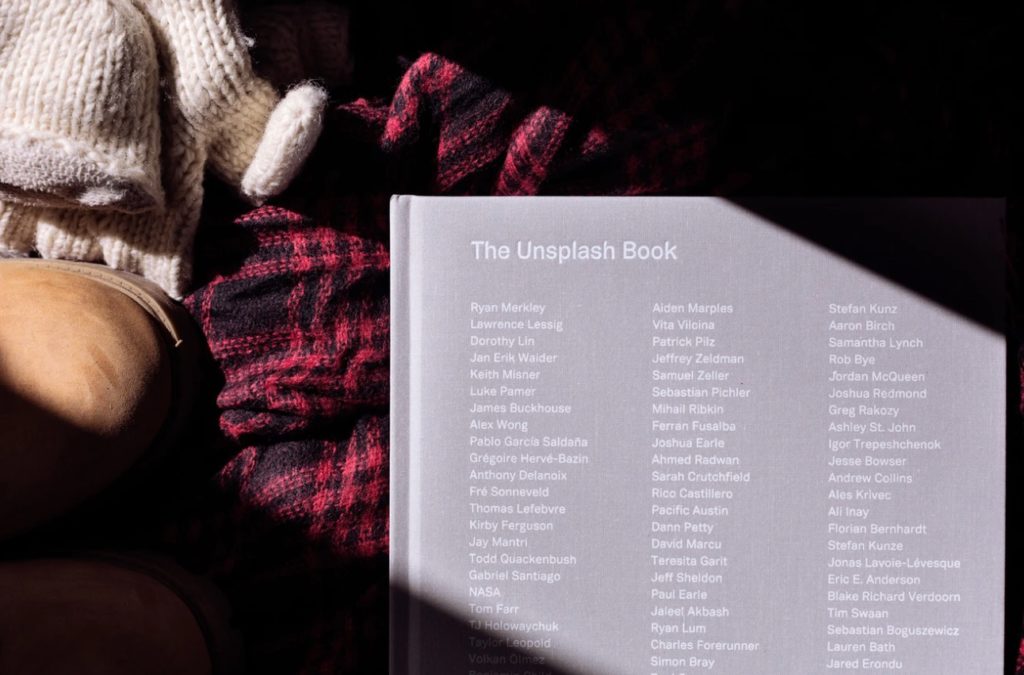La brand advocacy è quando ti piace talmente tanto qualcosa che usi (e/o chi lo fa) da consigliarlo spontaneamente al resto del mondo, il branded content è un contenuto (di qualunque tipo) commissionato da un’azienda e pubblicato a casa dell’autore (che sia il suo sito o una piattaforma esterna). Confonderli è molto facile, un po’ perché tendiamo a non credere al primo (come se non ci capitasse mai di consigliare un prodotto a qualcuno), un po’ perché tendiamo a pensare al secondo come una specie di seconda scelta o di scorciatoia.
Togliamoci subito un pensiero, anzi due. Il primo: proviamo a tradurli, così facciamo felice il direttore. Una buona traduzione di brand advocacy è passaparola (si perde un po’ di forza, ma non di sostanza); una prima traduzione di branded content potrebbe essere contenuto firmato (è brutto, ma rende l’idea).
Il secondo pensiero da toglierci: chiederci se funziona. La risposta è semplice: funziona se fatto bene, non funziona se fatto male.
Fatto male = pago qualcuno per parlare bene di me o per copincollare un testo fornito da me. Sono soldi buttati dalla finestra, anzi, è come pagare qualcuno per farci un danno.
Fatto bene = seleziono un autore perché mi piace quello che fa (che siano testi, foto, video, illustrazioni o live) e remunero il suo lavoro perché produca qualcosa ispirato ai miei prodotti.
Aggiungiamo un elemento: per farlo benissimo l’ideale è trovare un’area di sovrapposizione tra consigliare spontaneamente un prodotto ed essere pagata per parlarne. Cerchiamo qualcuno cioè naturalmente disposto ad apprezzarmi e di cui apprezziamo lo stile. Per esempio: io adoro la Norvegia e i lettori apprezzano i miei reportage di viaggi. Se VisitNorvegia volesse fare branded content dovrebbe selezionare persone come me e non viaggiatori che, per dirne una, sognano Ibiza o la Thailandia. È la parte difficile del lavoro di fare comunicazione usando queste tecniche, ma è anche quella che aumenta a dismisura il ritorno sull’investimento. Invece ricevo spesso offerte per parlare di prodotti su cui l’unica cosa gentile che avrei da dire è: no, grazie. Al prodotto, non all’offerta. Non ci vuole molto: basta leggermi per più di due minuti. Le persone disposte a parlare (bene) di qualunque cosa per soldi sono le ultime di cui hai bisogno.
Togliamoci il terzo e ultimo pensiero: il branded content si dichiara, sempre. Con un tag, con una categoria, con una frase, in una pagina sul tuo sito. Facebook sta prendendo abbastanza sul serio il tema e ci ha dedicato un’intera sezione e un tool ad hoc: «le nostre regole prevedono che autori ed editori indichino con un tag i loro clienti se pubblicano post pagati» (mia traduzione per «Our policies require creators and publishers to tag their business partners in their branded content posts»). Non è un tag normale, ma un «with» che fa comparire la dicitura Paid e permette al cliente così taggato di vedere i dati sull’andamento del post.

Come per molte funzionalità non è ancora distribuita: ho chiesto di poterla utilizzare sulla mia pagina per potervi raccontare meglio come e quando usarla, sia come autori sia come clienti. Quello che conta, per questo primo approfondimento, è l’importanza di dichiarare quando un articolo è stato commissionato e pagato: se avete lavorato bene a tutto il resto questo non condizionerà il risultato dell’iniziativa, anzi.