Changing the World is the Only Fit Work for a Grown Man è uno dei libri consigliati su Wolf anche se, purtroppo, non ne è mai stata fatta una traduzione in italiano.
Al fondo del libro c’è una breve biografia dell’autore, Steve Harrison.
La biografia finisce con un invito a scrivere all’autore che suona così: «Come Howard Gossage, Steve Harrison incoraggia le persone a rispondere ai suoi lavori, e sarebbe felice se gli scrivessi una mail a harrisosteve@googlemail.com per dirgli cosa pensi del suo libro»:
Ora, visto che il libro parla molto dell’interazione con il pubblico, teorizzata e applicata in pratica da Gossage una cinquantina d’anni prima dei social e visto che avevo particolarmente apprezzato il libro, ho aperto il computer e iniziato a scrivere una mail.
E naturalmente – se leggi di Gossage capirai ancora meglio il perché di questo “naturalmente” – ho ricevuto una risposta e ho iniziato una sorta di corrispondenza epistolare con Harrison.
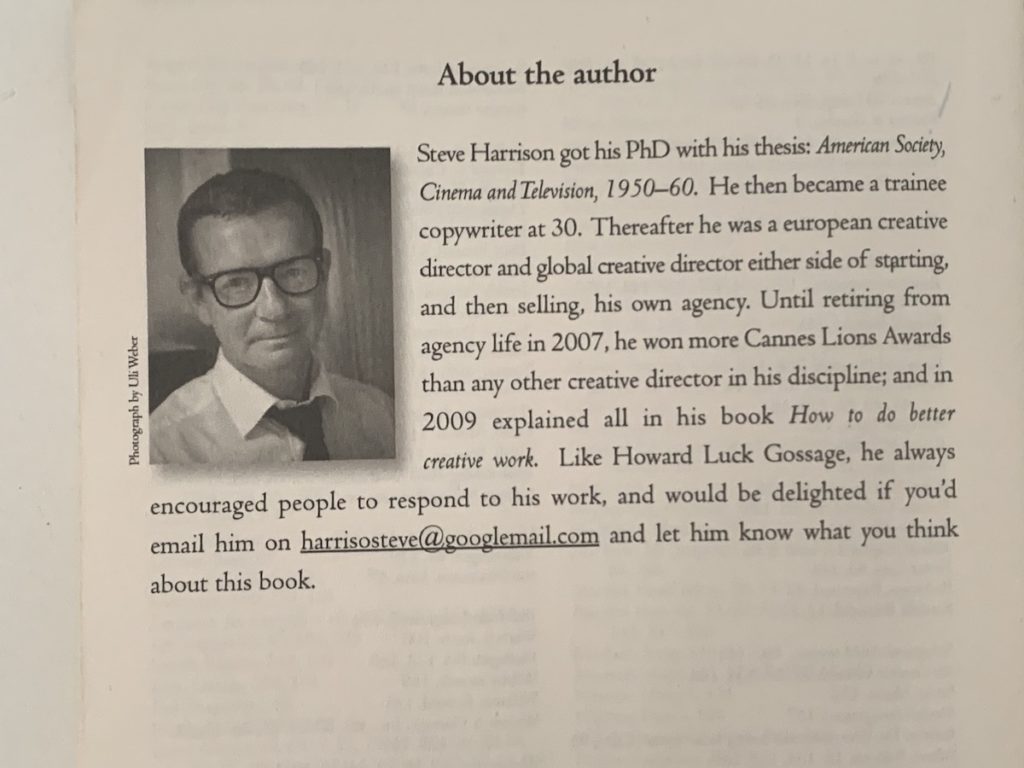
La parte interessante però non è tanto il fatto che ci sia questa corrispondenza ma il fatto che, ad un certo punto, Harrison mi ha proposto la lettura del suo ultimo libro, uscito in piena pandemia COVID-19 e rivisto come seconda edizione con un’appendice proprio dedicata alla situazione che si è creata in seguito all’emergenza.
Il libro parla di adland, cioè del magico mondo della pubblicità, e si intitola Can’t sell, won’t sell.
Il titolo, come spiega lo stesso Harrison nella sua introduzione, è una semi-citazione da Dario Fo (!), la cui commedia Non si paga! Non si paga! è stata tradotta in inglese con il titolo Can’t Pay? Won’t Pay!
Sempre nell’introduzione c’è spazio per una citazione dedicata ad un altro comedian, Ricky Gervais, che nell’introduzione ai Golden Globes 2020 ha detto alle star presenti in sala:
«If you do win an award tonight, don’t use it as a platform to make a political speech. You’re in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. So if you win, come up, accept your award, thank your client and your God, and fuck off, alright?»
(riadattamento del sottoscritto) «Se vinci qualcosa stasera, non usare questo spazio per fare un discorso politico. Non sei nella posizione di insegnare proprio niente al pubblico. Non sai niente del mondo vero. E allora, se vinci, vieni qui, prendi il tuo premio, ringrazi il tuo agente e il tuo dio e te ne vai affanculo, va bene?»)
La doppia citazione dovrebbe farci capire molto bene cosa possiamo aspettarci: è un testo che, soprattutto per chi si occupa di comunicazione, marketing e pubblicità rischia di apparire dissacrante.
Harrison parte dall’analisi di Patrick Collister dei vincitori al Festival internazionale della creatività “Leoni di Cannes” del 2019 (per la cronaca, di Leoni Harrison in carriera ne ha vinti tre d’oro, cinque d’argento e due di bronzo). Nel suo discorso Cannes Conflicted (lettura integrale consigliatissima!), Collister nota che dei 28 premiati, solamente sei dichiaravano come obiettivo un incremento delle vendite. E gli altri, allora?
Be’, gli altri erano tipo Viva la vulva. Uno spot per Libresse che puoi vedere qui.
Questo lavoro è stato premiato a Cannes con un oro nella categoria Leone di Vetro perché «fa davvero la differenza» e mostra che «il marketing può aiutare a cambiare il mondo».
È stato realizzato per combattere i miti, le insicurezze e gli stereotipi che devono subire le donne quando si parla dei loro genitali.
Ora, la prima cosa interessante da notare è che nessuno degli otto creativi che lo ha realizzato è una donna.
Il che significa, scrive Harrison (come al solito il riadattamento è del sottoscritto)
«che lo stesso progetto diventa esempio dei “radicati squilibri, ingiustizie e diseguaglianze di genere” che il Leone di Vetro vorrebbe “cambiare in maniera positiva”.
[…]
Tom Callaghan, che ha lavorato come direttore creativo a Saatchi & Saatchi ha commentato così:
«Il filmato si rivolge al mercato che esiste già: donne che non si vergognano di avere il ciclo, la cui famiglia non le evita o le fa dormire in una capanna separata quando hanno le mestruazioni (come avviene in Nepal), o per le quali il budget familiare semplicemente non consente di ricorrere a questi “lussi”.
«Libresse (il cliente dell’agenzia creativa, ndr) ha bisogno di crescere: per quanto il prodotto piaccia agli utenti attuali, non acquisteranno più del necessario. Quindi la crescita e le vendite devono sicuramente provenire dai mercati emergenti. Questo spot non fa nulla per convincere le donne del terzo mondo che il prodotto porterà loro benefici durante il ciclo. Ma, ehi!, ha vinto un oro a Cannes, quindi son tutti felici. Tranne forse la donna che risciacqua lo straccio insanguinato del mese scorso nel fiume in modo da poterlo usare la prossima volta».[…]
«E Tom non menziona il fatto che Viva la vulva non sarebbe mai mostrato nel mondo conserrvatore dove Libresse potrebbe in effetti fare la differenza. Anzi, potrebbe essere considerato offensivo dalla maggior parte di quelle persone che vorrebbe rassicurare».
Ok, e a questo punto siamo tutti uomini a parlare di uno spot rivolto alle donne. E questo la dice lunga, giusto?
D’altra parte, nella Cannes del cambiamento solamente l’11% dei premi sono stati vinti da donne.
Torniamo ad Harrison: il suo punto cruciale, l’idea intorno alla quale ruota tutto il libro è il fatto che il cosiddetto purpose marketing, l’idea che il marketing e la pubblicità debbano fare la loro parte per cambiare il mondo sono diventati parte di un’agenda sempre più scollegata dalla realtà, un’agenda di élite liberal (un po’ come le star di Hollywood cui si rivolge Gervais nel suo discorso ai Globe, per capirci) che si illude di far qualcosa di veramente utile per gli altri, abbracciando questa o quella causa.
E nella visione di Harrison, non si tratta affatto di autentico interesse per migliorare il mondo. Tant’è che non tutte le buone cause vanno bene: non è che si vedono, per esempio, campagne pubblicitarie a sostegno delle proteste ad Hong Kong.
Il purpose marketing è diventato un tool (sì, come la SEO, i social, il Business manager di Facebook e via dicendo). Un tool che rischia anche di essere non-autentico e ipocrita.
Sul blog The Ad Contrarian, Bob Hoffman avvalora, in buona sostanza, la tesi di Harrison e definisce l’interesse per Black Lives Matters da parte dei brand un Carnevale dell’Ipocrisia. Perché?
Be’, perché
«Nel 2017, le aziende americane hanno spostato 2.600 miliardi di dollari in paradisi fiscali. La Nike da sola 12,2 miliardi di dollari.
[…] Quando le aziende cercano in ogni modo di evitare di pagare le tasse, stanno danneggiando in ogni modo i cittadini e le cittadine che hanno più bisogno di istruzione, case, salute, servizi sociali. Se ai brand interessa davvero Black Lives Matter, devono smettere di privare il paese di quelle risorse necessarie per migliorare le vite delle persone che ne hanno bisogno nascondendo i loro profitti in paradisi fiscali. Piaccia o meno, in buona sostanza, pagare le tasse è il motore che finanzia la giustizia sociale».
«Diciamolo in maniera così semplice che anche un amministratore delegato possa capirlo: non puoi essere per la giustizia sociale e contro il pagamento delle tasse».
E quindi, diventa un po’ complicato, per esempio, essere a favore delle tesi di Extinction Rebellion – un movimento prima di tutto anticapitalista – e contemporaneamente lavorare in un’agenzia che ha fra i suoi clienti compagnie petrolifere. Giusto per fare un esempio pratico.
La soluzione? Quella che propone Harrison te la lascio scoprire leggendo il suo libro, che è veramente un tuffo nell’acqua frizzante. Anche quando non sei d’accordo con lui.
Per esempio, io non sempre sono sicuro di esser d’accordo con lui; ammetto che un po’ credo all’esigenza di lavorare a brand, aziende, meccanismi che abbiano come obiettivo anche quello di migliorare il mondo.
Ma pensandoci bene, poi, come fai a credere davvero a manifesti come quello del Business Roundtable quando leggi il dato delle tasse eluse da parte delle aziende americane?
Il punto è che se l’attenzione alle buone cause non si accompagna alla coerenza aziendale (in tutto: dal modo in cui vengono trattate e pagate le persone fino al modo in cui si persegue il profitto e quindi al modo in cui si comunica), allora diventa solo un tool, appunto.
È un po’ la sensazione che ho avuto personalmente quando ho avuto la fortuna di trovarmi a New York proprio durante il Pride dell’estate ’19: pubblicità sulle pagine dei giornali coi colori del Pride, loghi ridisegnati con i colori del Pride, negozi drappeggiati con i colori del Pride, carri di aziende di ogni genere con i colori del Pride. Sì, anche di quelle aziende che eludono le tasse.
D’altra parte, dall’Italia, dove non abbiamo nemmeno una parola corrente per diversity (e infatti la chiamiamo… diversity. Un po’ come privacy), diventa davvero complesso immergersi in questo tipo di discorsi e di considerazioni, che pure sono riflessioni fondamentali, visto che il purpose marketing si affaccia prepotentemente anche da queste parti. Come tutte le parole chiave, come tutti i tool.
Quel che potremmo fare è usarlo in maniera consapevole, in modo che non serva solo a vincere un premio, far parlare del brand nelle conversazioni social. In modo che non sia solamente un travestimento perfetto per il carnevale dell’ipocrisia.
Altre letture:
Per approfondire, ti consiglio anche la lettura di The Empathy Delusion
L’immagine di apertura
È un fotogramma di Viva La Vulva
