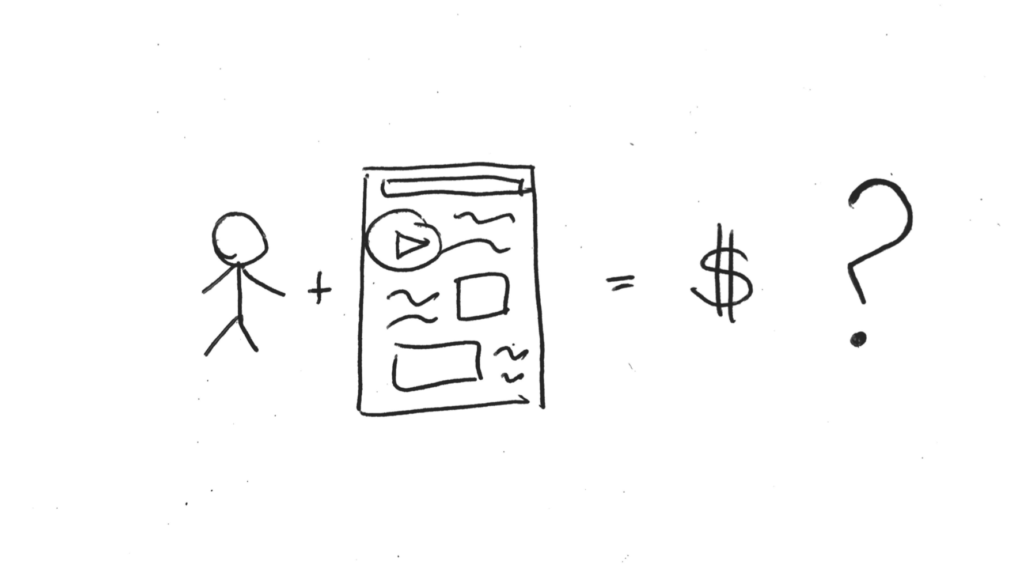Il mese di dicembre del 2018 è stato molto interessante per chi segue le dinamiche di uno dei settori che ha maggiormente risentito dei contraccolpi della cosiddetta disruption digitale. Mi riferisco, naturalmente, al giornalismo.
In Italia, Enrico Mentana ha lanciato il suo Open (tutto gratis, modello di business: la pubblicità) e Milena Gabanelli (insieme a Marco Castelnuovo e Martina Pennisi) ha scritto che l’unico modo per far bene giornalismo online è il paywall.
In campo internazionale c’è stato il lancio del crowdfunding di The Correspondent (modello di business: membership, paga quanto puoi).
Sono tre eventi che sono molto utili per la comunità di Wolf. Così come è utile fare un viaggio nel tempo, attraverso mezzi e modelli economici, cercando di tener conto delle peculiarità italiane e di non perdere di vista le prospettive internazionali, visto che le barriere geografiche oggi non sono più un problema per i contenuti.
Per forza di cose, in quel che segue ci saranno delle semplificazioni, ma cerchiamo di dare uno sguardo quanto più approfondito possibile a quel che abbiamo visto succedere nel mercato giornalistico affinché ci serva da esempio per considerare sia quanto di buono abbiamo visto in questi anni sia gli errori commessi, per rendere conto a noi stessi della complessità della realtà e per affrontare a dovere il mondo che cambia.
Il vecchio modello di business
In questo disegnino brutto (*) sintetizzo il vecchio modello di business del giornalismo.

Lo schema è piuttosto chiaro.
L’editore produce l’oggetto giornale. Lo distribuisce laddove il giornale viene acquistato. Lo spedisce agli abbonati. Le copie si trovano nei bar (dove, per inciso, vengono lette “gratis” da un numero non determinato di persone) o sui treni o sugli aerei o in biblioteca oppure arrivano alle persone in altri modi (copie lette in famiglia, da amici e simili). In realtà fra le fonti di ricavo dovrebbero essere aggiunte altre voci specifiche (ad esempio le necrologie, gli annunci).
Il punto cruciale di questo modello di business è il controllo oligopolistico della produzione e della distribuzione, che alza a dismisura i costi per l’ingresso nel mercato di nuovi soggetti.
Televisione e radio competono, in questo meccanismo, per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari. Competono relativamente per quanto riguarda l’attenzione che le persone possono porre ai contenuti, giacche si tratta di media che prevedono tipi di fruizioni diverse rispetto a quello del giornalismo cartaceo. Inoltre, giornalisti “cartacei” sconfinano nei due media, spesso trainando l’autorevolezza delle testate che rappresentano (ad esempio, nei talk show).
In Italia, poi, c’è una situazione peculiare, che vede il giornalismo essere anche un’istituzione. Lo spiega bene Mario Tedeschini-Lalli:
«In nessun Paese come nel nostro il “Giornalismo” è anche una istituzione. Una istituzione con i suoi organismi che stabiliscono chi è e chi non è giornalista, con leggi e norme che si applicano solo a loro. Una istituzione che è descritta anche da rapporti di lavoro strettamente regolamentati da contratti che con difficoltà si adattano alla rivoluzione in atto nelle redazioni, al mutare dei prodotti e dei flussi di lavoro. Una istituzione nella quale tutto si tiene, che è resa paradossalmente più vulnerabile dalla sua rigidità strutturale: incapace ad adattarsi, rischia infatti di crollare tutta insieme. Questa prospettiva spaventa giustamente tutti, ma la struttura rende quasi impossibile modificare il “Giornalismo” e i “giornalisti”, rebus sic stantibus, non vedo infatti come in questo quadro sia possibile far vivere quella cultura della sperimentazione frequente e rapida, dei fallimenti visti come pietre miliari dello sviluppo – sulla quale pure giustamente ti interroghi e che sembra anche a me condizione necessaria per costruire qualcosa nel mondo digitale».
Si noti, tuttavia, che non c’è una corrispondenza diretta fra le copie vendute e quelle lette e che è ipotizzabile che siano molte di più, le persone che fruiscono del contenuto giornalistico senza pagarlo. Questo si riflette, fra l’altro, sui dati che le concessionarie comunicano agli investitori, quando si introduce il concetto di lettori nel giorno medio. Ecco come comunica ancora oggi, per esempio, un noto giornale nazionale italiano:
«Un’opportunità unica di visibilità per l’inserzionista per un prodotto contestualizzato di grande qualità per un totale di 120.000 copie cartacee + 18.000 abbonamenti tablet per un totale di 458.000 lettori g.m.».
Insomma: si tende ad esaltare la quantità di lettori raggiunti. La convenienza specifica di giornali e inserzionisti, in quella fase storica, era sostanzialmente la medesima: arrivare a quante più persone possibili. La combinazione dei due elementi genera come conseguenza un oligopolio dell’autorevolezza (che esiste in un certo senso anche all’estero, non solo in Italia). In un mondo non digitale, il sistema si tiene. Sia economicamente sia in termini di fiducia: è un mondo tutto sommato impermeabile e autoconfermativo.
Questo fa sì che raramente ci si metta a lavorare in termini di ricerca e sviluppo. In altre parole, gli editori non si preoccupano più di tanto di raggiungere i lettori potenziali, quelli che non leggono, non comprano il giornale, rifiutano uno o più brand giornalistici, non si fidano, non hanno mai comprato ma potrebbero farlo, non si sono mai abbonati ma potrebbero farlo.
Quando tutto si tiene solo i più illuminati si muovono per tempo.
Le conseguenze del digitale, degli smartphone e delle piattaforme
Facciamo un rapido viaggio nel tempo e arriviamo ai giorni nostri.
Il passaggio dalla carta al digitale ha avuto conseguenze radicali che possiamo sintetizzare così
- chiunque nel mondo può raggiungere chiunque abbia una connessione a internet
- chiunque può produrre contenuti
- chiunque può distribuire i suoi contenuti o addirittura mandarli in diretta con costi ridottissimi
Se, dunque, un tempo eravamo nell’era della scarsità dei media, siamo entrati prima nell’era dell’abbondanza e poi nell’era della sovrapproduzione dei contenuti (e del conseguente sovraccarico informativo)
In un contesto simile, le news si sono trasformate in commodity, in prodotti sostanzialmente indifferenziati
Inoltre, visto che le persone hanno una quantità finita del loro tempo da dedicare a questi contenuti, ogni singolo contenuto compete, potenzialmente, con tutti gli altri, siano essi prodotti professionalmente o meno.
Quindi:
- i canali distributivi e i soggetti emittenti, che prima erano finiti, ora sono potenzialmente illimitati
- anche i contenuti sono potenzialmente illimitati
- la quantità di attenzione che le persone possono prestare a contenuti rimane finita (diciamo non più di 12 delle 24 ore, a voler essere proprio ottimisti)
- sulle piattaforme come Facebook si trovano masse di persone e attraverso gli strumenti evoluti che fanno di Facebook una piattaforma coi super poteri (come il Business Manager) e grazie alla raccolta massiva di dati, gli inserzionisti possono raggiungere tramite Facebook stesso i loro potenziali clienti
Questo, come spiega Ben Thompson (la cui teoria dell’aggregazione rimane una delle letture più importanti da fare per fare ordine e comprendere la portata dirompente di digitale e piattaforme) ha avuto due conseguenze fondamentali
- la disponibilità sostanzialmente illimitata di inventario di annunci pubblicitari
- lettori e clienti potenziali sono diventati due entità distinte, il che significa che editori e inserzionisti pubblicitari non hanno più gli stessi interessi
La prima conseguenza individuata da Thompson fa sì che il costo di un annuncio pubblicitario indifferenziato tenda inesorabilmente verso lo zero.
La seconda, invece, è tanto più vera quanto più una pubblicazione è generalista (lascia comunque ancora oggi margini di operatività per il giornalismo locale e per quello dedicato a specifici argomenti tematici).
Gli investitori – fatte salve le debite eccezioni e i rimasugli di rendite di posizione e di un passato che difficilmente tornerà –, hanno visto evolvere la loro convenienza specifica, che è diventata quella di arrivare a quante più persone possibili fra coloro che possono realisticamente diventare clienti utilizzando i mezzi più convenienti. Bisogna, cioè, arrivare ai clienti potenziali (in altre parole, bisogna far rendere l’investimento pubblicitario), tenderanno ad investire sempre di più laddove sono sicuri di intercettare in maniera più compiuta il bisogno latente (i social, Facebook in particolare) o il bisogno consapevole (i motori di ricerca) delle persone. Ecco perché Google, Facebook e Amazon sono, al momento, le tre piattaforme su cui si concentrano gli investimenti pubblicitari del digitale.
Ecco spiegato per quale motivo altri investitori iniziano addirittura a produrre contenuti per conto proprio o a rivolgersi a figure che nel frattempo sono emerse prepotentemente, approfittando dell’abbattimento dei costi di produzione e distribuzione dei contenuti: i cosiddetti influencer.
Aggiungiamoci un altro elemento. La disintermediazione ha come conseguenza non solo il fatto che le persone possono scegliere a quale tipo di fonte informativa abbeverarsi (senza una guida, un’educazione, questo comporta anche il rischio di bersi l’ennesima teoria del complotto). Ma anche il fatto che il concetto di verità giornalistica vacilli: diventa più facile individuare errori o peggio.
In tutto ciò, ci sono le scelte fatte dagli editori.
Come è stato interpretato il digitale? Tanto per cominciare, non è vero che è stato messo tutto gratis, come ricorda Mark Potts (Washington Post) nella traduzione in italiano di Mario Tedeschini-Lalli:
«Contrariamente a un mito molto diffuso, non c’è mai stato il “peccato originale” dei quotidiani che in qualche modo non avrebbero pensato a mettere a pagamento le edizioni digitali nei primi tempi: in realtà noi parlavamo continuamente di modelli di contenuti a pagamento e il memorandum di [Robert G.] Kaiser [vicedirettore del Washington Post, autore 20 anni fa di un primo, visionario rapporto sul digitale] arrivò a ipotizzare che fosse possibile guadagnare soldi vendendo singoli articoli a migliaia di lettori per pochi centesimi al pezzo. In effetti, molti dei primi siti e dei primi prodotti online dei giornali – compreso Digital Ink, il primo servizio online del Post – erano a pagamento. Essi si scontrarono, tuttavia, con limiti tecnologici e resistenze del pubblico che resero non funzionali gli abbonamenti. L’alternativa fu la vecchia carta di riserva dei giornali, la pubblicità – che si dimostrò però poco efficace con la fine della scarsità dei media e la concorrenza di Google, Craigslist e molti altri sugli investimenti pubblicitari che i giornali erano abituati a dominare. Credetemi, se nei primi tempi avessimo potuto immaginare come indurre le persone a pagarci direttamente le informazioni digitali, lo avremmo fatto».
Inoltre, ricorda sempre Tedeschini-Lalli nel medesimo pezzo
«in Italia i “contenuti del giornale” non sono stati praticamente mai gratis online (a parte alcune primissime e limitate esperienze) e a tutt’oggi essi sono a pagamento: se si vuol leggere in versione digitale ciò che Corriere della Sera, Repubblica, Stampa, Messaggero ecc. hanno stampato nella copia cartacea in edicola, occorre pagare».
E allora cosa c’era, di gratis? Alcuni contenuti, breaking news, cose che nel tempo sono diventate commodity e poi, purtroppo, notizie irrilevanti, curiosità, video comici, incredibili, pazzeschi, mostri marini e altre amenità che con il giornalismo hanno ben poco a che vedere. Ma hanno tanto a che vedere con la scelta di puntare tutto – per monetizzare i contenuti online – sul traffico.
Cioè sui click.
Da qui, piani editoriali irrilevanti, social invasi di curiosità, tutte le homepage con le stesse notizie perché si insegue in maniera indifferenziata il click.
Si tratta, da un certo punto in poi, di una scelta consapevole. Murdoch, con The Times, per esempio, ha puntato sul paywall fin dal 2010.
Quando ci si lamenta, per esempio, di Google o di Facebook è bene ricordare che essere o meno su Google News o su Facebook è una scelta degli editori. Paradossalmente, queste grosse piattaforme potrebbero anche fare a meno delle notizie dei giornali tradizionali.
La conseguenza di questa scelta consapevole è che il percepito dei giornali perde di consistenza. Se ci aggiungiamo l’afflato anti-istituzioni degli ultimi anni la frittata è fatta: il mondo che cambia, le piattaforme, gli smartphone, l’era della sovrapproduzione, la disintermediazione, le scelte consapevoli, le piattaforme, gli inserzionisti, la divergenza di interessi, diventano concause di una crisi che sembra sostanzialmente irreversibile.
Nuovi modelli di business
Nella disamina sui nuovi modelli di business per il giornalismo del futuro abbiamo elaborato un modello-Wolf. È un modello che, preso atto di una crisi strutturale, che non è solo del giornalismo, cerca di proporre un approccio differente a quanto visto fin qui, consapevoli del fatto che il mondo è cambiato. Viviamo in un mondo digitale. Il che non significa progettare buone pagine online. Significa ripensare l’offerta giornalistica.
Per questo, tanto per cominciare, si parla della necessità di lavorare mettendo a profitto le compentenze diverse del tavolo delle competenze
- editoriale
- di marketing
- di vendita
- di design
- di programmazione e sviluppo
Queste cinque competenze vanno a comporre e valorizzare un prodotto giornalistico che è prima di tutto un servizio per un pubblico, magari per una vera e propria comunità di lettori, che si può progettare, costruire, aggregare e gestire. Sul tema, abbiamo costruito una sezione di Wolf che abbiamo chiamato Quaderno del community building e del community management, perché pensiamo che alle cinque competenze fondamentali vada affiancata quella del community manager.
Secondo il principio del trattare anche un’impresa giornalistica come qualsiasi altra impresa proposto già da Marc Andreessen nel 2014, si suggerisce di diversificare le fonti di ricavi, secondo l’economia delle soluzioni parziali.
Inoltre, si introduce il concetto di contenuto aggregatore/attrattore. È un contenuto che può funzionare da attrattore per un pubblico, su un territorio (fisico o tematico o entrambe le cose), attraverso le piattaforme, per/con i brand.
Ecco, infine, uno schema (sempre fatto secondo il principio del “disegnino brutto”) che mostra come immaginare il singolo contenuto per la monetizzazione e per massimizzarne diffusione, distribuzione, promozione, consegna e ritorno.

Qui il contenuto sfrutta le cinque leve possibili per farsi raggiungere o per raggiungere il pubblico:
- SEO
- social
- pr (pubbliche relazioni)
- dm (messaggistica diretta)
- pay (pagamento per la distribuzione)
Inoltre, il contenuto si può sviluppare anche offline. Per esempio, con eventi dal vivo, incontri e altre possibili leve di monetizzazione. È così che viene concepita la membership, è così che si stanno muovendo nuovi editori, come The Correspondent, Zetland, The Information e molti altri.
Open
Mentana, direttore del TgLa7, a luglio del 2018, annuncia che vuole creare un nuovo giornale digitale, per i giovani e fatto dai giovani. Il 18 di dicembre, dopo le selezioni, Open – questo il nome scelto per il giornale – apre i battenti.
Raggiungibile online all’indirizzo open.online ha dato vita a una serie di critiche di ogni genere. Alcune degne dei migliori troll, altre estremamente motivate e centrate. Fra queste ultime, una delle più interessanti è quella di Valerio Bassan.
Valerio scrive:
Il principale problema di Open non è rappresentato dal contenuto, dalla tecnologia o dalle persone che ci lavorano. Il principale problema di Open è che eredita il difetto originale dei legacy media: non è concepito né gestito come un prodotto che deve conquistarsi un mercato e sopravvivere al suo interno.
Nel corso di media product management che tengo alla Scuola di Giornalismo Università Cattolica cerco di spiegare agli studenti che qualsiasi nuova iniziativa in ambito media – sia essa un podcast che parla di tennis o un mensile cartaceo che si occupa di fashion – deve obbligatoriamente rispondere a una domanda: il prodotto che stiamo per lanciare risolve un problema? Fornisce un servizio?
Se volessimo utilizzare il lean canvas che vedete qui sotto per analizzare il lancio di Open, non avrei difficoltà a riempire le caselle che riguardano il business model (come Enrico Mentana ha più volte spiegato, sarà basato al 100% sull’advertising), né a delinearne l’unfair advantage (beneficia del traino online del giornalista più seguito d’Italia). Mi troverei tuttavia in difficoltà con la compilazione del resto del canvas. Qual è la “unique value proposition” che differenzia Open da competitor con più storia, risorse e pubblico — da il Post a Fanpage.it? Quale il problema che affronta? Quali le soluzioni che propone? Quali sono i suoi KPI di riferimento? Ma soprattutto, quale segmento di utenti si propone di raggiungere?
Quella dei “giovani” non è una demografica. Nessuna startup si presenterebbe a una sessione di pitching dicendo “ci rivolgiamo ai giovani”. C’è un abisso tra utenti 18-24 e utenti 25-34. Tra donne e uomini. Tra residenti a Roma o nella campagna umbra. Cambiano le loro storie, le loro diete mediatiche. Cambia il modo in cui organizzano informazione e conoscenza nelle community di cui fanno parte. In che modo “Open” può aiutarli a comprendere meglio la realtà in cui si muovono? Di quali strumenti hanno bisogno perché questo avvenga?
Non possiamo lavorare nel giornalismo fingendo che non sia una vera e propria industria, che non faccia parte di un sistema economico con le sue regole, le sue strutture, i suoi modelli. Sarebbe ora di smetterla di pensare che per costruire un prodotto editoriale di successo basti il CONTENUTO. Così come è un peccato veder nascere una nuova redazione che si definisce moderna ed è al tempo stesso sprovvista di persone in grado di occuparsi di strategia digitale e di gestione del prodotto: se siamo arrivati a parlare di giornalisti pagati 8 euro al pezzo, o a salutare l’assunzione di 20 praticanti come un mezzo miracolo, la colpa è anche di scelte sbagliate a livello di management aziendale.
Personalmente, se avessi la forza economica di lanciare un nuovo prodotto editoriale gratuito e “pensato per gli smartphone” nel 2018, creerei un Axios. Oppure, se fossi Mentana e avessi il suo seguito, ipotizzerei una proposta editoriale alla The Correspondent chiedendo ai miei fan, in modo veramente “open”, di costruirla con me — partendo da una domanda fondamentale: “Hey, sto per lanciare un giornale, cosa vorreste che diventasse?”
Le osservazioni di Valerio hanno suscitato parecchie considerazioni nel medesimo thread su Facebook, nel quale è intervenuto – a tratti anche ironicamente – lo stesso Mentana.
Modello di business – Qui c’è poco da dire: l’idea di fondo è che l’informazione debba essere gratis. E quindi Open ha i banner pubblicitari. Il Sole24Ore ha pubblicato un po’ di conti. Mentana ha anticipato 200mila euro e a tendere investirà 1 milione nel progetto. Per la raccolta pubblicitaria – che, in assenza di dati di traffico anche solo potenziali è affidata alla fiducia – ci pensa la concessionaria di Cairo. Ecco cosa scrive ancora il Sole24Ore:
«attraverso Cairo Pubblicità, società di Urbano Cairo, proprietario di La7 e azionista di maggioranza di Rcs. Secondo fonti vicine al dossier, sarebbero stati raccolti circa 300mila euro, al lordo delle commissioni di agenzia».
L’obiettivo è quello di raggiungere un milione di utenti unici giornalieri (come scrive Engage.it).
Blogo, una realtà digitale nata nel 2004, ha impiegato una decina d’anni per arrivare a un milione di utenti unici giornalieri, giusto per avere un termine di paragone in una realtà che conosco bene (ho fondato nel 2005 TvBlog e diretto Blogo dal 2012 al 2016).
Purtroppo, rispetto a quel che abbiamo detto fin qui, questo modello di business rischia di essere gravemente insostenibile.
Quando si fa notare a Mentana che “poche centinaia di migliaia di euro”, come lui stesso le ha definite su Facebook, sono lunari per qualsiasi startup e quando gli si fa notare che, dal lancio del Fatto quotidiano in poi nessuna realtà giornalistica italiana ha potuto godere di una simile visibilità in partenza, il direttore del TgLa7 ha spiegato, laconicamente:
«Centinaia di migliaia di euro è quel che serve per far diventare realtà la promessa di fare venti nuovi praticanti con contratto a tempo indeterminato. Continuate a parlare di un’altra cosa. Ma il mio impegno era questo, e costava tanto».
Ora, senza voler fare i gufi e considerando che, al momento, non risultano posizionamenti organici di Open nelle prime cinque pagine di Google, la strada da fare per arrivare al milione di utenti unici giornalieri auspicato è molto lunga.

Cosa succederà quando finirà l’investimento di Mentana? E quando gli investitori vorranno i numeri?
Senza un cambio di rotta significativo, per i motivi che abbiamo già visto qui sopra (strutturali, non dovuti a Open stesso), Open rischia davvero di non aver successo. E questo vuol dire che, se le cose andranno così, da qualche parte ci sarà qualcuno che, fregandosi le mani penserà e dirà: «vedi? Il digitale non funziona, per il giornalismo. Non ci è riuscito nemmeno Mentana».
Se volessimo poi individuare altri elementi di critica, purtroppo, non si possono non citare
- la scelta faticosa e infelice della scritta bianca su fondo nero

- la visione del giornalismo come elemento che presidia le breaking news, la sostanziale mancanza di differenziazione rispetto a quel che esiste già
- una visione della SEO riduttiva (c’è un SEO specialist, in Open, ma Mentana scrive: «senza avvantaggiarci dell’ aiutino dei motori di ricerca. Anzi, andando sulle pagine di Google potete pensare che Open esista soltanto per i commenti che ne hanno fatto gli altri siti e giornali (grazie – a proposito – a tutti quelli che ne hanno parlato, che ci hanno dato il benvenuto, comunque ci abbiano giudicato). Ma è proprio così che vogliamo vivere questa storia». E se cerco il virgolettato su Google, Open non esce!)
E allora che si fa?
L’idea che il paywall sia l’unico modo
Il pezzo di Milena Gabanelli in cui si parla di modelli di business per il giornalismo conclude così:
«per tutti i siti, ergere un paywall, o forme di abbonamento è l’unico (e sano) modo per assicurare un futuro all’informazione. E alla verità, che conta, e costa. A quel punto saranno gli utenti, e non gli algoritmi, a premiare i migliori».
A supporto di questa tesi viene proposta una lettura del digitale che osserva i fatti dal punto di vista dei giornalisti e dei giornali, mai o quasi mai dal punto di vista delle piattaforme – che esistono – e delle persone che fruiscono dei contenuti.
Ecco, allora, che in una delle infografiche proposte si vede che sono le piattaforme a beneficiare della circolazione delle notizie su di esse. E, relativamente alla SEO, si sostiene che
«quando si cerca una notizia su Google non c’è garanzia che il primo risultato sia l’articolo fatto dall’inviato andato sul posto. Potrebbe benissimo essere una ripresa «fatta in casa», ma con un utilizzo di parole chiave «ad effetto» che la posizionano meglio sul motore di ricerca».
Le cose non stanno esattamente così, come sanno bene tutti coloro che hanno avuto la pazienza di affrontare il nostro quaderno SEO. È vero che anche piccoli siti possono posizionarsi per le parole chiave che vengono cercate dalle persone. Ma è altrettanto vero che, se i grandi siti utilizzano correttamente le medesime strategie, avranno senz’altro la priorità per il motore di ricerca, soprattutto se producono contenuti originali, unici ed esclusivi.
Inoltre, la metrica del traffico sui siti di informazione ha un valore solo per la scelta consapevole del modello di business basato sul click. E per tutto il meccanismo editori-investitori-centri media
Non solo. In questa corsa alla richiesta di pagamento da parte delle persone, Gabanelli non mette mai in discussione il prodotto. Ovvero: siamo proprio sicuri che osservando la presenza digitale dei giornali italiani, questa sia appetibile per un pubblico pagante? Che cosa si potrebbe fare per cambiare le cose? Come si potrebbe ripensare l’offerta giornalistica? Come si possono far sentire le persone parte del prodotto giornalistico?
Nessuna di queste domande viene posta all’interno di questo articolo. Anzi, si ribadisce più volte che in gioco non c’è il giornalismo ma che
«In gioco c’è la verità, e la verità ha un costo».
Della verità giornalistica abbiamo già detto. In gioco, secondo chi scrive, c’è il giornalismo, non la verità.
E se sono personalmente convinto della necessità di diversificare le fonti di introiti e dell’abbandono del modello basato sul click, sono anche estremamente convinto di una serie di questioni:
- le piattaforme vanno usate, non demonizzate
- non si recupererà la centralità del giornalismo a colpi di (altre) leggi, ecco perché la direttiva Copyright continua a non essere una buona idea (per tacer del fatto che il lavoro giornalistico non è lavoro di creazione artistica da tutelare)
- è l’intero modello di lavoro da mettere in discussione
Quando, per esempio, Gabanelli scrive:
«la presenza in Rete di chi fa informazione è sempre più impegnativa e, in quanto tale, dispendiosa. Sia perché impone una redazione ampia (una ventina di persone regolarmente contrattualizzate, solo per il presidio delle breaking news dell’online) aperta 24 ore 7 giorni su 7. Sia perché è difficile individuare una modalità di lavoro coerente con il vecchio quotidiano di carta, che costituisce ancora oggi circa il 75% dell’intero fatturato di un giornale»
si vede, ancora una volta, la presenza di un retaggio ancorato ai vecchi modelli. Chi l’ha detto che si deve presidiare le breaking news? Le commodity vanno trattate per quel che sono: oggetti che, per un mercato in cui ciò che conta è il brand, l’autorevolezza, il percepito, hanno un valore singolo tendente allo zero. Zetland, per esempio, produce 2-3 notizie al giorno, non di più. Eppure è interamente digitale.
Paradossalmente, allora, anche se la visione di Gabanelli è orientata a trovare un modello economico per un giornalismo che si rivolge alle persone paganti, rimane ancorato a vecchi modelli di pensiero, prima che economici. Esattamente come Open.
The Correspondent
Il lancio di The Correspondent, invece, è completamente diverso. Basato sull’esperienza di un primo lancio in Olanda, grazie al traino di giornalisti noti e di un crowdfunding ben progettato, cinque anni dopo ecco che la startup olandese – che nel frattempo è rimasta sostenibile dopo una raccolta fondi record – ci prova negli Stati Uniti.
Il crowdfunding è stato progettato in due anni. E dopo il successo eccezionale (più di 2,5 milioni di dollari raccolti), la testata si prende sei mesi prima di iniziare le pubblicazioni.
Ci sono tutti gli ingredienti del caso, prima di tutto alla ricerca di un Oceano Blu rispetto alla tradizione giornalistica, rispetto allo stato dell’arte.
L’idea di The Correspondent è, prima di tutto, un giornalismo diverso, rivoluzionario, rivolto al pubblico e di pubblica utilità. Il modello di business è a pagamento – ricorsivo – ma secondo la regola del “paga quel che puoi”.
La partecipazione di Jay Rosen al Late Night di Trevor Noah è la miglior spiegazione di quel che potrebbero fare anche in Italia grandi personalità del nostro giornalismo come Milena Gabanelli o Enrico Mentana.
Tutto il resto
Qualsiasi mercato a rischio di commoditizzazione – perdonate l’orrenda parola – non può che trarre lezioni preziosissime da quel che ho provato a raccontare fin qui (**). Il tavolo delle competenze e la capacità di pensare digitale, di progettare digitale, sono elementi fondamentali per qualsiasi business. Progettare digitale significa pensare come aveva suggerito benissimo ancora una volta Mario Tedeschini-Lalli nella sua lettera aperta a Mentana:
«L’universo digitale è ancora in radicale trasformazione e occorre quindi distinguere le tendenze e le caratteristiche generali dei fenomeni dalle soluzioni contingenti. Ne segue un secondo consiglio di carattere generale: non progettare un giornale “online”, progetta un giornale digitale aperto a ogni canale disponibile, anche se ora pensi di necessità al web».
Togliamo “giornale online” o “giornale digitale” e pensiamo a prodotti online, aperti a ogni canale disponibile.
A come disegnarli, a come gestire le community, a come comunicarli, venderli, promuoverli, a come farci su azioni di marketing, in maniera integrata.
Si può fare senza necessariamente guardare all’estero: siamo capaci di farlo anche noi.
(AP)
___
(*) I disegnini brutti sono derivanti dalla mia incapacità sostanziale con il disegno e sono, al tempo stesso, un omaggio a Ben Thompson di Stratechery. Inoltre ho le prove che funzionino nel supporto alla comprensione del testo
(**) Questo pezzo è sicuramente da aggiornare e sistemare nel tempo, ma costituisce una specie di pietra miliare per Wolf.